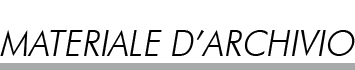I primi hacker del software
Se vogliamo andare alla ricerca delle prime avvisaglie di quell’etica, legata strettamente ad un ambito tecnico specifico, che ha fornito le basi per l’attuale fenomeno del software libero/open source, dobbiamo fare un salto all’indietro negli Stati Uniti dei primi anni ’60.
La storia è ambientata a Cambridge, e precisamente all’interno del Massachusset Institute of Technology. Fu proprio qui che nacque il Tech Model Railroad Club, un club di modellismo in cui si radunarono diversi appassionati di scienza, tecnologia e informatica. Il club era il luogo adatto per fare esperienza sui circuiti elettrici, in attesa di poter mettere le mani sui computer mainframe a schede perforate dell’Ibm, a quel tempo riservati a un ristretto “clero” di tecnici.
Fu proprio presso il TMRC che nacque il termine “hack”, che in futuro avrebbe conquistato grande successo e si sarebbe anche prestato a numerosi fraintendimenti e slittamenti di significato. Negli anni ’80 il vocabolo hacker ha assunto per l’opinione pubblica un valore dispregiativo, legato al concetto di “pirata informatico”. Per i protagonisti degli eventi di cui ci stiamo occupando, un “hack” era la brillante risoluzione di un problema di qualsiasi tipo (non solo tecnologico o legato all’informatica) in maniera creativa, arguta e soprattutto gioiosa. Quello che rendeva speciale un “hack” era la passione della scoperta, la voglia di partecipare attivamente ad un processo creativo, l’amore per la sperimentazione. Il fine non era la risoluzione del problema in sé, ma l’atto stesso di cercare di risolverlo. Il fulcro dell’attenzione era cercare di scoprire i segreti dell’elettronica, testare i limiti delle macchine per capirne il loro funzionamento, usando spesso tecniche non convenzionali. Era un modo di lavorare che rifuggiva dalle guide e dai manuali e che si basava sull’apprendimento spontaneo, pratico e antiburocratico.
Quando al MIT arrivò il Tx-0, il primo computer a transistor, alcuni membri del TMRC si lanciarono a provarlo, essendo quest’ultimo circondato da una minore burocrazia dell’Ibm 704. Lavorando in maniera inconsueta rispetto agli utenti “normali” di questo computer, che lo usavano prevalentemente per applicazioni, questi appassionati iniziarono a scrivere diversi programmi per facilitarne l’utilizzo, come assembler e debugger .
Nel passare numerose ore di fronte alla console del Tx-0, questi amanti dei computer stavano andando inconsapevolmente a costituire una cultura che avrebbe prosperato e si sarebbe arricchita negli anni, consistente di principi etici, linguaggio comune, leggende folkloristiche e che sarebbe stata raccolta, a partire dagli anni ‘70 all’ interno del Jargon File, “un compendio del dialetto hacker che illumina diversi aspetti della tradizione, del folklore e dell’umorismo degli hacker” .
Il modo in cui operavano questi membri del TMRC lasciava trasparire un’etica e una visione dell’ informatica tutta particolare. Per questi appassionati i computer dovevano essere accessibili ogni volta ce ne fosse stato bisogno da chiunque li volesse usare. Per capire le macchine bisognava “metterci su le mani” , aprirli e smontarli per capire quali fossero le loro potenzialità. Lo spirito di ricerca e sperimentazione li spingeva a rifiutare qualsiasi forma di burocrazia. Vi era la convinzione che per ottenere i migliori risultati e le più grandi innovazioni il processo di creazione dovesse essere lasciato libero e spontaneo, non pianificato e privo di regole arbitrarie. Le regole erano utili solo se efficaci per una situazione specifica. Un’altro principio importante, che sarebbe stato poi fondamentale per la nascita del movimento open source, stabiliva che l’informazione dovesse essere libera.
Questo era ancora più vitale in un’epoca in cui l’informatica era ancora agli inizi e i computer erano visti come qualcosa di misterioso. Ecco che i primi hackers iniziarono a far vivere una prassi in cui chiunque apportasse dei cambiamenti a un programma rendesse il proprio lavoro disponibile agli altri utilizzatori, in modo che potessero lavorarci sopra senza essere costretti a “reinventare la ruota”.
Questo punto derivava sì da motivi tecnici legati all’arretratezza e alla giovinezza della scienza informatica di quei tempi ma dipendeva in gran parte dall’attitudine anticonformista e sperimentatrice di questi utilizzatori.
Lo spirito che li accompagnava era ben diverso da quello dell’IBM, che invece di puntare sull’innovazione faceva riferimento a concetti di stabilità e a meccanismi ampiamente testati e collaudati, senza spingersi in maniera incauta oltre certi limiti.
Le macchine dell’IBM di quegli anni erano infatti caratterizzate da alta affidabilità e stabilità, ma anche da un livello molto basso di interattività con l’utente.
Si rivelavano poco adatte ad uno stile di programmazione basato sull’improvvisazione, sulla curiosità e sull’esplorazione.
Già ai suoi albori la cultura hacker mostrava caratteri squisitamente meritocratici, secondo i quali si veniva considerati dal gruppo unicamente per le proprie azioni e non secondo criteri quali il ceto, l’età, il genere, la razza o la confessione religiosa.
A chiudere il quadro vi era inoltre la convinzione che il codice di un programma dovesse essere considerato come un testo a tutti gli effetti. Il codice sorgente possedeva una sua bellezza intrinseca e poteva essere guardato nello stesso modo in cui si guarda un’opera d’arte. Un programma non doveva semplicemente assolvere bene la sua funzione, ma doveva anche essere scritto con un certo stile. Nacquero anche particolari forme di competizione, in cui si cercava di scrivere una stessa funzione impiegando il numero minore di righe di codice. Questo modo di concepire la programmazione ha, a nostro avviso, avuto un ruolo decisivo nella esportazione dell’etica hacker ad ambiti esterni a quello informatico e ha costituito la piattaforma per la nascita di diverse pratiche sociali. Concepire il programma come un testo pone infatti le basi per l’estensione dell’“etica hacker” a diversi temi, quali la libertà dell’informazione, la proprietà intellettuale, il diritto all’educazione e all’apprendimento.
Nel 1961 fece il suo ingresso una nuova macchina, il Pdp-1, regalata al Research laboratory of electronics (Rle) del MIT dalla Digital Equipments Corporation (DEC).
Questa si rivelò fin dall’inizio la macchina più adatta agli hackers, poiché era stata progettata per un utilizzo più interattivo, pensata com’era più per la ricerca che per l’elaborazione numerica. Gli hackers iniziarono subito a scriverci dei programmi per poterla usare al meglio e, potendola utilizzare più spesso del Tx-0, cominciarono a servirsene nei modi più svariati e impensabili: a ritmo serratissimo nacquero assemblatori, compilatori musicali, giochi di scacchi professionali e giochi di guerre spaziali.
Il modo di lavorare degli hackers iniziava intanto a essere riconosciuto e al MIT ormai numerosi professori avevano capito che per imprimere un maggiore sviluppo alla scienza informatica era necessario permettere l’utilizzo dei computers a più gente possibile. Per questo motivo cercarono di costruire un sistema time-sharing , che avrebbe permesso a più persone di utilizzare contemporaneamente lo stesso computer. Ma i sistemi time-sharing esistenti non soddisfavano le pretese degli hackers, così i planner del IA lab diedero il compito di crearne uno nuovo ad alcuni di loro. Crearono l’Incompatible Time Sharing System. Questo sistema incarnava in sè vari principi dell’etica hacker: aveva una struttura aperta, e stimolava la collaborazione e lo scambio reciproco tra gli utenti. Questo sistema operativo multi-utente, comune a molti utilizzatori, si impose soprattutto per le possibilità di continua implementazione che offriva agli utenti, che iniziarono a lavorarci sopra in modo cooperativo per migliorarlo costantemente.
Alla fine degli anni ’60 l’etica hacker si stava diffondendo anche in altri luoghi, soprattutto in California, dove si stava creando una comunità di programmatori con molti punti in comune con quella del MIT. Iniziavano a svilupparsi i laboratori della Stanford University e della Carnegie-Mellon e una nuova infrastruttura, basata sull’integrazione di diverse tecnologie, stava per avvicinare i programmatori dei diversi centri di ricerca: Arpanet.